1917. Nuovi libri e classici, inserti di giornale e articoli. Rassegna di alcune novità nella storiografia in occasione dei cent’anni dalla rivoluzione d’Ottobre
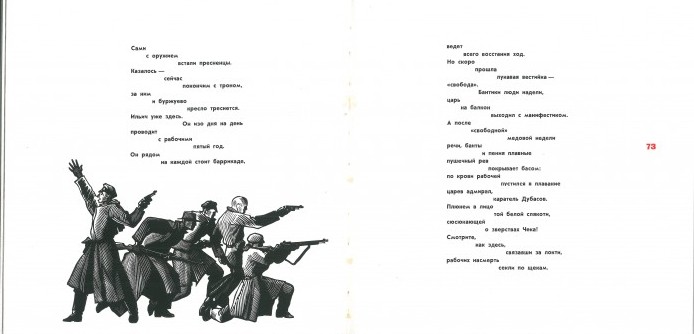
Avevo già commentato la piacevole sorpresa di sentirmi meno solo nella difesa della rivoluzione russa dall’ondata di calunnie e di esecrazioni con cui soprattutto negli ultimi trent’anni era stata liquidata anche da gran parte della sinistra. Compresa quella “centrista” (per usare la classica definizione leniniana), che elogiava “la rivoluzione non russa”, in contrapposizione a quella “russa” ridotta alla “presa del Palazzo d’Inverno”, che era un modo furbesco per incartare la vecchia tesi dell’azione minoritaria di una setta mossa da un’obsoleta ideologia, o un “Colpo di Stato” dalle conseguenze fatali. A tale schema ricorreva anche chi contrapponeva una Rosa mitizzata (e mutilata) a Lenin, come facevano persino diversi esponenti di Democrazia Proletaria, con cui polemizzavo trent’anni fa in Lenin, Rosa e il partito e in Lenin, Rosa, e la questione nazionale..
La prima sorpresa gradevole l’ho avuta dal fantasioso supplemento a puntate del Manifesto dedicato alla rivoluzione russa, che immagina di avere un suo corrispondente da Pietrogrado. Le corrispondenze sembrano ricalcate sulla Storia della rivoluzione russa di Lev Trotskij, e la trovata è simpatica, anche se manca l’indicazione delle fonti e non aiuta quindi a indirizzare verso una lettura più sistematica. Ma è un piacevole segnale di inversione di tendenza.
La seconda, l’ho già anticipata in una breve recensione (1917 OTTOBRE ROSSO) di un libro pubblicato dal Corriere della sera. Avevo segnalato con particolare piacere un’intervista a Boris Kolonitsky, professore della European University di San Pietroburgo, che addirittura esagerava un pochino nel sottolineare la ineluttabilità della rivoluzione indipendentemente dall’azione di quelli che sistematicamente per cento anni sono stati additati come sobillatori prezzolati, Lenin e Trotskij, di cui peraltro sottolineava la statura di “leader politici di talento”. E lo diceva nella Russia di Putin. Va detto che nel frattempo, per cancellare ogni illusione su quel regime tanto apprezzato da qualche residuato nostrano di un lontano passato, quell’Università è stata soppressa. Vedi qui…
Meno imprevisto l’inserto Rileggere la rivoluzione russa nel numero di ottobre di Le Monde Diplomatique, con un editoriale di Serge Halimi dal titolo inequivocabile: Il secolo di Lenin, che si conclude con una interessante riflessione:
La «fine del comunismo» sembrava aver concluso il grande dibattito che aveva contrapposto le due correnti della sinistra internazionale dopo la rivoluzione russa, poiché la sconfitta di uno dei due protagonisti sembrava sancire la vittoria dell’altro, cioè la rivincita della socialdemocrazia sul suo fratello minore più turbolento.
Halimi osserva che il trionfo è stato di breve durata, perché “per la corrente riformista il centenario della presa del Palazzo d’Inverno coincide con una serie di rovesci in politica”:
Spazzata via la dinastia Clinton; Anthony Blair, Felipe Gonzales e Gerhard Schröder che si sono dati agli affari; non parliamo poi di François Hollande… E contemporaneamente, una forma di impazienza, di radicalità, rinasce nella maggior parte dei paesi…
Ma la spiegazione del rispetto maggiore di vari storici nei confronti di un evento così lontano parte da una considerazione realistica delle ragioni della vittoria dei bolscevichi di fronte a forze interne ed esterne preponderanti: solo il consenso di massa dovuto alle scelte di fondo sull’opposizione netta alla guerra e sull’autodecisione dei popoli, può spiegare che mentre l’impero austroungarico, quello tedesco e quello ottomano furono irreparabilmente distrutti al termine della Grande Guerra, la rivoluzione russa riuscì a recuperare rapidamente gran parte dei territori dell’impero zarista.
Quanto sia difficile far ragionare una sinistra imbottita da decenni di frasi vacue per cancellare la sua identità l’ho capito vincendo la tentazione di non leggere il libro di Stephen A. Smith. Se mi fossi orientato in base alla recensione apparsa sul supplemento letterario del Manifesto, Alias, lo avrei ignorato. Prima di tutto il libro di Smith, (La rivoluzione russa. Un impero in crisi, Carocci, Roma, 2017) veniva messo sullo stesso piano di un paio di altri libri men che interessanti che avevo già letto e che venivano presentati assai benevolmente, dall’altra in una intera pagina il recensore non riusciva a far capire di che parlava il libro. Non mi sono scoraggiato e ho fatto bene. Gran parte delle banalità contenute nella recensione erano dovute alle convinzioni dell’autore dell’articolo, Stefano Garzonio, a cui era sfuggita la novità del libro, e che suppliva con frasi vacue come questa:
Smith offre l’opportunità unica di poter ripercorrere le diverse fasi della storia russa con un occhio al loro significato più propriamente universale, all’opposizione tra socialismo e capitalismo anche in una prospettiva che conduce alla contemporaneità e alle nuove situazioni conflittuali del nostro tempo tra Russia e occidente.
La recensione tira in ballo perfino la “fine della spinta propulsiva dell’Ottobre”, frase citatissima ma che non spiega niente, dato che serviva a Berlinguer per annunciare uno sganciamento parziale dall’URSS senza entrare nel merito, senza distinguere la penosa involuzione finale dal tentativo originario, ed anzi dando per scontato che l’Unione sovietica brezneviana fosse l’erede della rivoluzione. Ignorando invece la vera novità del libro di Stephen Smith che è la netta e più volte dichiarata rottura con la tendenza storiografica dominante negli ultimi trent’anni, che ha insistito sempre sulla continuità tra Lenin e Stalin, Garzonio sostiene che l’importanza della rivoluzione sarebbe stata soprattutto “nell’edificare uno Stato che non solo seppe tener testa a lungo al capitalismo, ma soprattutto fornì un alto tributo di sangue come decisivo baluardo contro la vittoria del fascismo”. Una frase fatta sentita mille volte nei partiti di derivazione staliniana e che serviva a nascondere la tragedia dell’URSS degli anni Trenta che tanto concesse al fascismo già prima degli accordi Ribbentrop-Molotov.
Comunque non mi sono fatto scoraggiare dalla delusione per una presentazione banalizzante, e non mi sono pentito dell’aver affrontato la lettura del libro di Stephen Smith. La scelta della periodizzazione tra il 1890 e il 1928 permette di lasciar fuori il periodo del Grande Terrore, la cui realtà è stata ricostruita largamente da una preziosa memorialistica dei sopravvissuti, e anche in diverse opere d’insieme, affrontando invece il problema del fallimento dei molti tentativi di riforma dell’impero che hanno preceduto la rivoluzione del 1905 (che è la grande assente in molte delle pubblicazioni in circolazione).
Smith insiste in molte pagine sulle “notevoli continuità fra lo Stato zarista e quello sovietico”, precisando però che in larga misura si sviluppano solo dopo la “stabilizzazione del regime bolscevico” e soprattutto ad opera di Stalin e della sua “rivoluzione dall’alto” (termine peraltro poco convincente, se si pensa allo sterminio della maggior parte dei protagonisti delle due rivoluzioni). Smith ritiene che “l’autocrazia non era un regime immobilista e decrepito, cieco ai cambiamenti che lo circondavano”, e che cercò di “tenere il passo militarmente ed economicamente con le maggiori potenze europee”, e descrive i vari tentativi di riforma, attribuendo però sempre il loro fallimento a Nicola II. Non solo per i suoi interventi per rimangiarsi le concessioni che era stato costretto a fare, ma per aver voluto fortemente la guerra col Giappone e la partecipazione alla Grande Guerra, nell’illusione che potessero essere un antidoto alla rivoluzione.
Smith non è un comunista, e i suoi commenti rivelano che probabilmente non si sarebbe schierato al fianco dei bolscevichi, ma è uno storico serio e smonta facilmente le interpretazioni faziose che ignorano tutti i fattori che hanno spinto i bolscevichi a mutare molte delle loro convinzioni. Ad esempio riconosce che il loro progetto nel 1917 “era quello di una società socialista basata sul potere dei soviet, sul controllo da parte dei lavoratori, sull’abolizione dell’esercito professionale e su ampi diritti democratici – società che avrebbe dovuto nel lungo periodo portare a una rivoluzione internazionale dei lavoratori, alla completa abolizione del capitalismo e alla riduzione dei poteri dello Stato a quelli della semplice amministrazione”.
E riconosce che fu il dover combattere una dura guerra civile e affrontare un collasso senza precedenti della vita sociale ed economica” a modificare le loro convinzioni, facendoli “tornare alla realtà.” È chiaro che non crede all’utopia, ma quel che importa è che non accetta la classica demonizzazione di Lenin basata sull’ignoranza di quel che ha scritto e detto per decenni. E soprattutto rifiuta di considerare la violenza spaventosa che si sprigionò nel corso della guerra civile come il prodotto di una scelta dei rossi:
Di fatto, se si considerano gli anni Venti (lo stalinismo degli anni Trenta fu tutt’altra storia), non è così ovvio che la società sovietica sia stata effettivamente più violenta rispetto al periodo zarista; gli storici spesso non riescono a rendere in modo adeguato quanto la violenza fosse congenita nella Russia tardoimperiale, resa manifesta dalle conquiste coloniali, dalla repressione della polizia, dalle controinsurrezioni, dal terrorismo di destra e di sinistra, dai pogrom, ecc.
Stephen Smith ha un’ottima conoscenza delle fonti per quanto riguarda la società russa e sovietica, ma più approssimativa nei confronti del dibattito interno al variegato partito bolscevico, che riferisce talvolta senza coglierne completamente la logica. Ma ha capito che la frattura decisiva è stata realizzata non prima del 1921, su cui dice:
Si pensi al ruolo delle conseguenze impreviste: in seguito alla ribellione di Kronštadt, il X Congresso del partito istituì il divieto temporaneo (ma mai revocato) delle frazioni all’interno del partito bolscevico, e proprio le accuse di “frazionismo” avrebbero fornito a Stalin un’arma potente con cui colpire l’opposizione.
Smith ammette che “Lenin ha una considerevole responsabilità nelle istituzioni e nella cultura che permisero a Stalin di arrivare al potere. Ma “dal punto di vista logico – spesso ignorato da chi considera lo stalinismo come sorto senza soluzione di continuità dal leninismo – è che se la carica di segretario generale fosse andata a Bucharin o Trotskij, gli orrori dello stalinismo non sarebbero mai avvenuti, sebbene l’arretratezza economica e l’isolamento internazionale avrebbero comunque limitato fortemente il loro spazio di manovra.”
Il libro di Stephen A. Smith non apporta nulla di veramente nuovo rispetto alla monumentale opera di Carr (a cui d’altra parte tributa un doveroso omaggio) o all’impostazione di Rabinovitch che ho recentemente ricordato sul sito (Riflessioni sui bolscevichi), ma ha il pregio di smontare la storiografia faziosa che ha dominato gli ultimi decenni, e di rendere un sincero omaggio ai protagonisti della rivoluzione:
Non arriveremo mai a comprendere la Rivoluzione russa a meno di non renderci conto del fatto che – nonostante i loro molti difetti – i bolscevichi erano infiammati dall’indignazione per lo sfruttamento che si celava nel cuore del capitalismo e per il nazionalismo rampante che aveva trascinato l’Europa al mattatoio della Prima guerra mondiale. Né potremo capire l’anno 1917 senza uno sforzo di immaginazione che catturi di nuovo la speranza, l’idealismo, l’eroismo, la rabbia, la paura e la disperazione che ne furono all’origine: il desiderio bruciante di pace, il profondo risentimento nei confronti di un ordine sociale diviso tra chi aveva e chi no, la rabbia per le ingiustizie che caratterizzavano la società russa. Questi sono i motivi per cui milioni di persone in tutto il mondo – che non potevano prevedere gli orrori del futuro – abbracciarono la rivoluzione del 1917 come la possibilità di creare un mondo nuovo di giustizia, uguaglianza e libertà.
